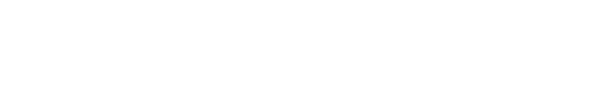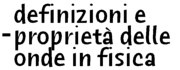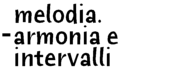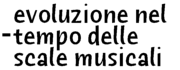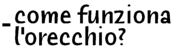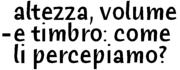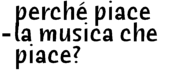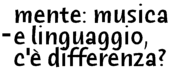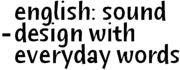Melodia:
La percezione dei rapporti tra suoni consecutivi nel tempo corrisponde alla percezione della melodia. Quando fischiettate una musica che vi è rimasta impressa, o che vi piace, tipicamente ne state riproducendo la melodia, ovvero la successione di suoni legati da una serie di rapporti costanti che caratterizza una composizione originale. Dal greco mélos (canto), la melodia è ogni singola "voce" che costituisce una creazione musicale. Ad ogni istante di tempo corrisponde una ed una sola nota. In moltissime forme musicali, tra cui spicca la quasi totalità della musica leggera, la melodia è la parte più in evidenza di un brano, anche da un punto di vista timbrico, e quella che, in un certo senso lo identifica, tanto che, anche quando sentiamo una stessa canzone eseguita in diversi arrangiamenti, pure continuiamo a ritenere che si tratti della stessa canzone, in quanto propone la stessa melodia. Se la esaminassimo da un punto di vista più oggettivo, dovremmo constatare che la maggior parte dei suoni della canzone cambia, al variare dell'arrangiamento, ma che i rapporti tra suoni consecutivi eseguiti dalla voce principale sono rimasti gli stessi.
La melodia passa spesso in secondo piano in generi particolari, come alcune categorie di musica elettronica e in composizioni dove il ritmo assume un ruolo predominante.
Darne comunque una definizione ci restringe necessariamente a una serie di stili e canoni a noi comuni e soggettivi. Una melodia può anche essere descritta da ampiezza massima degli intervalli, tensione e rilascio, continuità e coerenza, cadenza, e forma. L'evoluzione naturale della melodia si ha, ovviamente, nell'armonia.
Armonia:
La percezione dei suoni simultanei, corrisponde al senso dell'armonia. L'armonia non è "fischiettabile" (a meno di tecniche strane), perché non corrisponde ad una singola "voce" in una composizione, ma piuttosto all'insieme di tutti i suoni che, istante per istante, sono percepiti simultaneamente. L'armonia, quindi, nasce dalla fusione di tutte le "voci". Da un punto di vista grafico potremmo dire che l'armonia è determinata, istante per istante, dalla lettura contemporanea (verticale) di tutti i righi di una partitura. Ad ogni istante di tempo non corrisponde una singola nota, ma l'insieme di più note, che si chiama accordo. L'armonia di un brano, tuttavia, non è definita da un singolo accordo, ma nasce dalla particolare successione degli accordi nel tempo. È da notare che, storicamente, la tecnica di fondere le voci si è sviluppata molto più tardi del canto monodico (cioè basato solo sulla melodia), e, corrispondentemente, nel corso dei secoli, la prassi compositiva ha subito immense trasformazioni. La musica polifonica non è nata fino al medioevo, quando si sviluppò l'organum, una semplice forma di armonia dove la melodia principale era cantata contemporaneamente a una trasposizione in intervallo di quinta o di terza.
Mentre nel linguaggio comune il termine "armonia" ha sempre un'accezione positiva, e si riferisce ad una situazione di equilibrio e proporzione, in musica, proprio per la presenza del "fattore tempo", l'armonia di un brano può assumere caratteri diversi in tempi diversi, e conosce sia accordi apparentemente stabili e statici, sia accordi che, invece, sembrano introdurre elementi di instabilità e sembrano contenere in sé la tensione ad essere "risolti" verso accordi più stabili. Nel gergo musicale ci si riferisce a queste due grandi classi di accordi col nome di accordi consonanti e dissonanti.
La teoria dell'armonia è la branca della teoria musicale che disciplina la successione degli accordi presenti in un brano, e che, possibilmente, individua le "buone regole" della prassi compositiva.
Intervalli:
Esistono alcuni intervalli musicali di rapporto tra le note che vengono quasi universalmente percepiti come piacevoli o fastidiosi, al di là delle differenze soggettive nella recezione del suono.
Primo fra tutti per consonanza è certamente l'intervallo di ottava:
Da un rapido esame delle frequenze utilizzate si scopre che l'intervallo percepito è l'ottava se il rapporto tra le due frequenze è esattamente doppio.
Gli intervalli non sono dunque regolati dalla differenza tra le frequenze, ma dal loro rapporto.
Tra gli intervalli percepiti in media come consonanti si sono individuati, oltre all'ottava, la quinta giusta (3:2 anziché 2:1 come nell'ottava) e la quarta giusta per la quale il rapporto diventa 4:3.