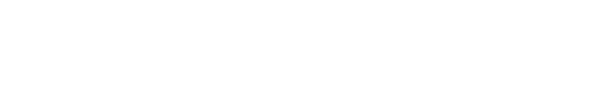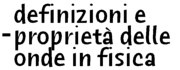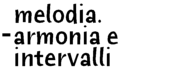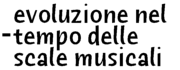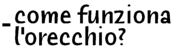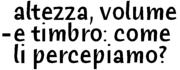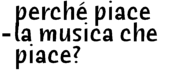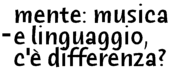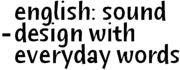La periodicità
Spettro:lo spettro in frequenza di un segnale è la rappresentazione dell'intensità di ogni componente pura (cioè sinusoidale) di quel segnale in funzione della frequenza. Per esempio, scomponendo la luce bianca in componenti monocromatiche mediante un prisma, si ricava lo spettro quando si misura l'intensità di ogni colore (cioè di ogni frequenza) che compone la luce bianca. |
La percezione umana delle onde, tuttavia, non è poi così fedele: l'apparato uditivo trasforma le variazioni di pressione che lo colpiscono in modo piuttosto complesso, e il cervello compie un enorme lavoro di elaborazione del segnale; un lavoro in cui l'allenamento, o l'abitudine, e quindi fattori culturali, e non solo fisici o fisiologici, giocano un ruolo di grande importanza. Domande apparentemente semplici diventano così incredibilmente complicate da esaminare e rispondere. Come distinguere oggettivamente suono e rumore? Si è pensato a classificazioni della periodicità e della composizione spettrale, ma ciò può diventare difficile o risentire anche di aspetti culturali. Se facessimo sentire un brano heavy metal a un compositore dell'800, sicuramente non avrebbe dubbi nel dire: "Si tratta di rumore, e della peggior specie!"
Proviamo ad astrarci per un momento dalla realtà e saliamo a un livello puramente teorico. Esaminiamo i seguenti tre campioni sonori:
Immediatamente si definiranno i primi due come suoni, il terzo come rumore.
La prima era un'onda sinusoidale, la seconda era un'onda arricchita con armonici, mentre l'ultimo suono era del rumore bianco, ovvero un suono casuale completamente privo di qualsivoglia periodicità. Se ci limitiamo a questi esempi, però, sembra confermata l'associazione più elementare: ad un'onda periodica si associa un'altezza ben definita, mentre al rumore bianco non sembra possibile attribuirla.
Proviamo però ad ascoltare questo:
Pur trattandosi di due onde, entrambe perfettamente considerabili come suono, il nostro orecchio non riesce a percepirle come distinte, e incapace di discriminare la loro altezza, percepisce un suono di altezza intermedia, ma dal carattere "ruvido", fastidioso. Un suono interpretato come rumore.
È possibile anche il contrario: produrre qualcosa che tecnicamente sarebbe definito come rumore ma che il nostro orecchio considera un suono gradevole e consonante.
Un tale effetto si ottiene sovrapponendo diverse bande di rumore bianco, ciascuna centrata su un multiplo intero della frequenza fondamentale prescelta. Quando le bande sono idealmente strettissime lo spettro diventa identico a quello di un suono gradevole, mentre quanto più le singole bande sono larghe, tanto più sopravviene il carattere di rumore. In tutti i casi l'onda sonora risultante possiede componenti periodiche, ma in senso stretto non è mai esattamente periodica, perché una componente casuale è sempre presente, tranne che nel limite di bande infinitamente strette.
Il rumore armonico sembra svelare una caratteristica fondamentale della percezione che convoglia l'informazione sul grado di consonanza o gradevolezza di un'onda sonora. Questa informazione è di valore inestimabile per i musicisti.
Nella pratica musicale ha, quindi, poca importanza la capacità di associare ad una data nota l'altezza (o la frequenza) corretta: questa capacità è chiamata "orecchio assoluto", ed è un dono che spetta a poche persone. Lo studio più recente a noi noto (Bahr, 1998) afferma che l'orecchio assoluto sarebbe una capacità derivante dall'esperienza, che non richiederebbe dunque particolari predisposizioni, confermando però l'età precoce dell'istruzione musicale come fattore di primaria importanza. Torneremo sulla questione successivamente, nella parte di questo documento dedicata agli aspetti scientifici della musica.
La rarità dell'orecchio assoluto confonde spesso i profani: sarebbe come dire che un pittore non riconosce i singoli colori di cui si serve per creare i propri quadri. In realtà, nella pratica musicale, sono molto più rilevanti queste capacità:
- la capacità di riconoscere l'intervallo formato tra due note consecutive;
- la capacità di riconoscere e utilizzare la sua qualità di essere "consonante" o "dissonante".
Esse sono direttamente associate al modo in cui i suoni vengono assemblati e organizzati per trasformarsi in musica. Ora che abbiamo acquisito le basi della fisica delle onde possiamo passare ad esaminare i princìpi base che la compongono.