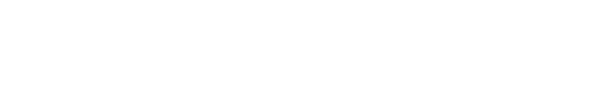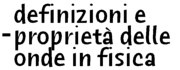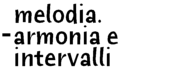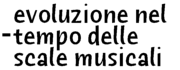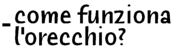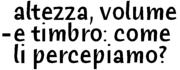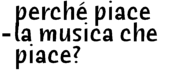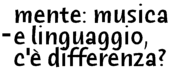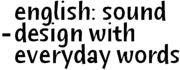Perché piace la musica che piace?
Nel Seicento si origina un primo tentativo di spiegazione a carattere meccanico della consonanza: essa verrebbe dalla parziale sincronia tra suoni che stanno tra loro in rapporti semplici, e dal modo in cui essi fanno vibrare il timpano. Nel caso della quinta do-sol, ad esempio, rapporto 3:2, ogni tre vibrazioni del sol le due note si troverebbero a stimolare il timpano in modo concorde.
Battimenti:in acustica sono le variazioni periodiche di intensità del suono percepite quando due suoni puri di frequenza vicina sono prodotti simultaneamente |
È palese come più il rapporto tra le frequenze fondamentali sia dato da numeri piccoli (interi), più precoci e numerosi siano gli armonici (che ricordiamo essere ogni oscillazione sinusoidale che è componente di un'oscillazione periodica) condivisi. È altresì immediato verificare che nel caso di intervalli dissonanti – semitono, tono, trìtono, settima maggiore – gli armonici in comune sono praticamente assenti o si trovano a ordini elevati, e viceversa si notano frequenti occasioni in cui essi originano battimenti.
Nell’Ottocento Hermann von Helmholtz fa il primo fondamentale passo nella direzione di conciliare estetica musicale e scienza a livello della psiche. Egli porta i battimenti al centro dell’attenzione, imputando loro la causa del fastidio generato da un insieme di suoni dissonanti. In effetti, oggi sappiamo che quando due note differiscono di poco in frequenza, ovvero ‘cadono all’interno della banda critica’, esse non vengono elaborate da fibre nervose e reti neurali distinte, circostanza che induce nel cervello condizioni di ambiguità. Per Helmholtz sarebbe proprio l’assenza di battimenti a generare l’effetto di consonanza tra due note. Va sottolineato che, per quanto detto, la teoria delle coincidenze e l’ipotesi di Helmholtz si implicano vicendevolmente:
niente di nuovo, quindi, salvo la considerazione del ruolo della psiche, ignorato dai meccanicisti. Oggi l’analisi del comportamento del sistema neurale cervello fatta dai neuroscienziati conferma che i treni di impulsi neurali generati da insiemi di suoni consonanti sono più semplici da elaborare, confermando che, come aveva ventilato Helmholtz, la preferenza per l’armonia classica ha origine biologica.
Le regole dell’armonia classica non sono una convenzione sopravvissuta attraverso i millenni, bensì il riconoscimento di caratteristiche percettive di base comuni agli uomini di tutti i tempi e paesi, nonché agli animali. La preferenza per l’armonia classica ha dunque origine biologica. Una composizione musicale che, pur nell’ambito della più ampia innovatività, non faccia proprio tale presupposto, è di norma poco accessibile al cervello ‘normale’ del fruitore medio di musica ‘seria’. Se ha dei meriti, essi sono più quelli della sperimentazione e dell’esplorazione di possibili vie di sviluppo per la musica futura, cosicché rimane apprezzabile e utilizzabile soltanto da una cerchia ristretta di specialisti e frequentatori del settore, in certo senso come per un fisico i risvolti di un esperimento scientifico, o i significati di un teorema per un matematico.